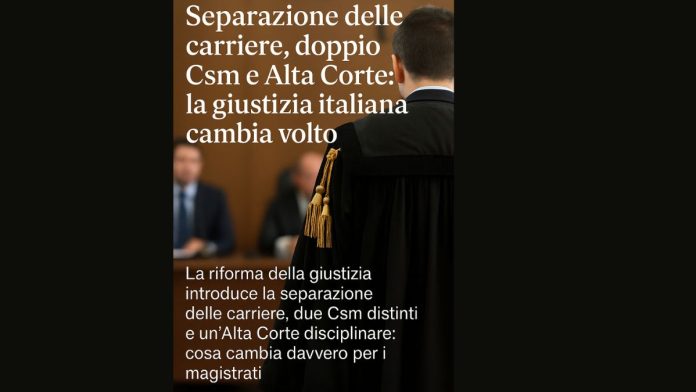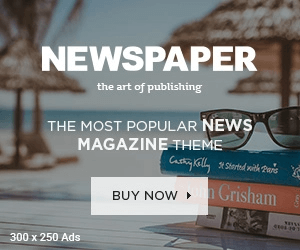Con l’approvazione definitiva in Senato, la riforma della giustizia segna un passaggio destinato a lasciare il segno: arriva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, una novità che cambia radicalmente l’assetto della magistratura. D’ora in avanti, chi giudica e chi accusa seguiranno percorsi professionali distinti, ciascuno con il proprio Consiglio Superiore della Magistratura, così da garantire maggiore indipendenza e neutralità nelle decisioni.
La riforma introduce anche un doppio Csm, con membri estratti a sorte e non più eletti, nel tentativo di ridurre il peso delle correnti interne che per anni hanno condizionato la vita delle toghe. Accanto ai due Consigli nascerà l’Alta Corte disciplinare, un organo nuovo e autonomo incaricato di valutare eventuali comportamenti scorretti dei magistrati. Le sue sentenze non saranno appellabili in Cassazione, una scelta che mira a rendere più snelli i procedimenti disciplinari ma che fa discutere per i rischi legati alla limitazione delle garanzie.
Il testo, già passato alla Camera, dovrà ora affrontare l’ultimo banco di prova: il referendum confermativo, previsto per la primavera del 2026. Solo in caso di voto favorevole, la riforma diventerà pienamente operativa. Nel frattempo, il dibattito resta acceso tra chi parla di “traguardo storico” per la giustizia italiana e chi teme un indebolimento dell’autonomia dei pubblici ministeri.
Tra entusiasmi e scetticismi, la separazione delle carriere rappresenta una svolta profonda e simbolica: una linea di demarcazione netta tra il potere di giudicare e quello di accusare, che mira – almeno nelle intenzioni – a restituire ai cittadini una giustizia più trasparente e imparziale.